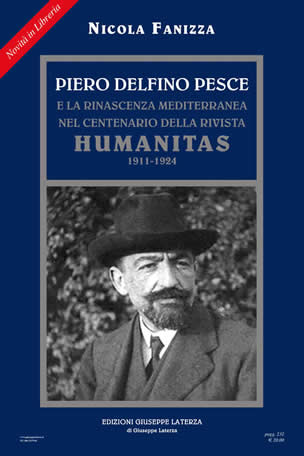Nicola Fanizza
PIERO DELFINO PESCE
Capitolo I
L’avventura editoriale di «Aspasia»
(1899-1900)
Gli anni napoletani
La visione dalla terrazza della casa paterna – che dà sul
grande giardino del palazzo dei Pesce – dei filari di peonie
e di alberi rari ed esotici; il profumo intenso e inebriante che esalava
in primavera dai fiori degli alberi di limone; lo stupore che investiva
lo sguardo quando, a volte, si individuava sui rami di quegli alberi
la presenza di uccelli dai colori sgargianti e dalla forma straordinaria;
i ricordi di mia madre che da quella terrazza si era trovata casualmente
ad osservare i rituali amorosi che avevano come protagonisti due
fratelli (figli di Piero Delfino Pesce) e due sorelle (figlie
di Vincenzo Fanizza), che abitavano in una casa contigua al giardino;
la prossimità distanziante da una persona di cui i miei genitori
parlavano spesso; il debito inconfessabile che si ha nei confronti
del proprio padre; e, infine, il desiderio di scrivere qualcosa che
abbia comunque a che fare con la città in cui si è nati.
A tutto ciò va aggiunto la casualità legata a un furto:
i ladri riuscirono a trafugare parte dei mobili – che, dopo la
vendita del palazzo, erano stati trasferiti nella casa dello scrivente –,
però, fortunatamente, abbandonarono per terra le lettere contenute
in un comò. Sono più o meno queste le motivazioni che – insieme
alla lettura di alcune di quelle lettere – hanno dato luogo alla
presente ricerca, che è incentrata sulla figura di Piero Delfino
Pesce e sulle sue imprese editoriali: la rivista quindicinale «Aspasia» (1899-1900)
e la rivista settimanale «Humanitas» (1911-1924). Fu chiamata
Humanitas anche la sua casa editrice.
Piero Delfino Pesce nacque a Mola di Bari il 1° giugno del 1874.
Era il primo di sette figli di un uomo di idee liberali e repubblicane
che da ragazzo era scappato da casa per arruolarsi, allo scoppio della
terza guerra di Indipendenza, nei Cacciatori delle Alpi di Garibaldi
e che sempre fu molto attento alla educazione dei suoi figli.
Dopo aver conseguito nel 1892 la maturità classica presso il
liceo di Molfetta, Pesce si trasferì in Campania per frequentare
la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di
Napoli. Qui incontrò Niccolò van Westerhout, un giovane
musicista di Mola che viveva da alcuni anni nella città partenopea.
Il compositore di origine olandese aveva rifiutato di seguire pedissequamente
la tradizione operistica italiana e aveva cercato di svecchiarla, rifacendosi
principalmente a Riccardo Wagner. La prima rappresentazione del Cimbelino di
Van Westerhout era andata in scena, nel Teatro Argentina di Roma, l’8
aprile 1892. E in quell’occasione il pubblico, insieme alla critica,
aveva accolto in modo lusinghiero l’esecuzione dell’opera.
Da qui la visibilità pubblica del suo autore e i suoi legami
con i maggiori rappresentanti della cultura napoletana del tempo. Van
Westerhout, infatti, instaurò rapporti amicali con Giulio Massimo
Scalinger, Roberto Bracco, Arturo Colautti, Salvatore di Giacomo
e Gabriele d’Annunzio.
A proposito di quest’ultimo, va detto che visse a Napoli dal
1891 alla fine del 1893 e sembra ormai certo che van Westerhout abbia
contribuito alla sua iniziazione «wagneriana».
D’Annunzio andava a trovare spesso il musicista molese nella
sua casa e, come si evince dalla testimonianza del comune amico Salvatore
Procida, «teneva per ore e ore van Westerhout al piano. Credo
che avremo letto, in meno di un anno, dieci volte il Tristano e
Isotta. Gabriele scriveva in quel tempo il Trionfo della morte. Tristano
ne occupava lo spirito con una morbosa ossessione. Voleva udire e riudire
il preludio assillante e pigliava appunti e quasi si attaccava cogli
occhi alla pagina che inizia con la tortura del filtro».
Un anno dopo la morte di van Westerhout, avvenuta il 21 agosto 1898,
Pesce farà stampare, in memoria del giovane compositore, un numero
doppio di «Aspasia». Sempre su questa rivista, nel
fascicolo del 25 novembre 1900, verrà riprodotto un articolo
del «Mattino» di Napoli, Doña Flor a Breslavia. Si
tratta della traduzione dal tedesco di una recensione – apparsa
sul quotidiano della Slesia «Schlesische Zeitung» – inerente
alla messa in scena, nel Lobe-Theater di Breslavia, della Doña
Flor di van Westerhout. Qui l’«anonimo» critico
musicale tedesco dice di aver «assistito a un vero trionfo, per
quanto postumo di un talento musicale indiscutibile»; che quella
di van Westerhout è una «musica piena di fuoco, di profonda
efficacia drammatica, ricca di passione e di colorito»; e, infine,
che «Doña Flor si darà presto ad Amburgo
e Dresda».
Pesce, durante gli anni napoletani, segue le lezioni di Giovanni
Bovio, il quale contribuisce in modo sensibile alla sua formazione
intellettuale e politica. Tuttavia in questo periodo i suoi interessi
sono precipuamente musicali: «A Napoli come talvolta avviene – scrive
Pesce –, fioriva la primavera lirica. Al San Carlo, che i giornaletti
umoristici avevano ribattezzato San Gaetano per la invadenza, in cartellone,
del repertorio donizzettiano, De Lucia e Battistini; al vecchio Fondo,
rimesso a nuovo col nome di Mercadante dalla Ditta Sonzogno per cura
del leccese Nicola Dasparo, repertorio francese con tenore Castellano
e il soprano Agresti, che era una Aida insuperabile. Ma noi studenti
si andava più volentieri al Bellini, non perché il posto
costasse meno, che gli studenti che non sgobbano non hanno di queste
malinconie, ma perché avevamo scoperto un giovane tenore meraviglioso,
giovanissimo e già tanto tanto bravo, ed eravamo come fieri
e gelosi della valorizzazione di questa nostra scoperta. Vi andavamo
per Caruso, e anche e più, per Annina Franco, che, in Faust,
era una Margherita ideale, bella brava squisita appassionata cantatrice
di cui eravamo tutti pazzamente innamorati, come si può essere
innamorati a diciotto anni, quando si distingue assai bene il fascino
dell’arte da tutte le altre cose.
Seguitammo in seguito a informarci del tenore nostro e di Annina nostra.
Costei non fece più carriera e ne restammo come personalmente
offesi, poi che avevamo riposto in lei tanta nostra fiducia. Ma Caruso
compensò a usura le nostre aspettazioni. Però non immediatamente.
L’anno dopo lo incontrai una sera al Gambrinus e mi disse con
rammarico che aveva inutilmente aspirato a essere l’interprete,
nella mia Mola, della Doña Flor, del van Westerhout,
scritta per la inaugurazione del nostro piccolo Comunale. Gli era stato
preferito, con il baritono Buti e la Bulicioff, il tenore Angioletti,
che era stato al S. Carlo un dolcissimo Lohengrin. “Già:
io non sono ancora celebre!” mi disse con quell’aria bonaria
e spavalda propria dei napolitani di genio che, come i bambini, sentono
Achille in seno, con la certezza che non mancherà mai il tempo
per metterlo fuori».
Frequenta i caffè, i concerti, i teatri e, attraverso la mediazione
di van Westerhout, entra in contatto col variegato ambiente culturale
napoletano.
Diventa amico di Roberto Marvasi, un raffinato intellettuale che in
seguito fonderà e dirigerà la «Scintilla».
Su questa rivista scriverà alcuni articoli in cui denuncerà i
legami fra camorra e politica e fra camorra e polizia. Il tema della
collusione fra la delinquenza organizzata e lo Stato è, inoltre,
presente nel saggio Malavita contro malavita, che Marvasi
pubblicherà, nel 1928, a Marsiglia, dove si è rifugiato
per sfuggire alle persecuzioni fasciste. Si tratta di un opuscoletto
che raccoglie una serie di conferenze che egli tenne presso la Sezione
del PRI di Marsiglia sul tema della diffusione della criminalità nel
Meridione d’Italia negli anni immediatamente successivi alla
repressione del Brigantaggio e sull’uso politico che i governi
post-unitari fecero di camorristi, mafiosi e delinquenti vari. E’ questo
un approccio di straordinaria attualità poiché le sue
tesi hanno trovato una ennesima conferma negli accadimenti della nostra
storia recente. Questa amicizia continuerà nel tempo ed è testimoniata
dalle lettere che Marvasi inviò a Pesce nel corso del 1922.
Sempre a Napoli entra in contatto con Alfredo Catapano, un poeta e
scrittore destinato a seguirlo, alcuni anni dopo, nell’avventura
editoriale di «Aspasia». La sua visibilità pubblica
non era, comunque, legata alla produzione artistica, ma a un evento
della vita della Napoli di quegli anni. Catapano era, infatti, anche
un valente avvocato e, in tale veste, aveva patrocinato la difesa di
una ragazza veneta sedotta da un ufficiale di cavalleria. Recatasi
nella villa comunale presso il galoppatoio dove l’ufficiale si
esercitava per chiedere aiuto per il figlio che doveva nascere si sentì rispondere: «Portalo
all’Annunziata». La donna aveva una rivoltella con sé e
uccise il cinico seduttore.
L’arringa terminò con queste parole: «Liberatela
in nome di tutte le donne che soggiacquero alla violenza, all’inganno,
alla frode; di tutte le donne che per un bisogno d’amore credettero
alla bontà e alla sincerità delle false promesse; di
tutte le donne esposte al vizio, alla miseria, alla fame e che trovano
la virtù di risorgere, di vivere e di rigenerarsi nell’amore
e nella protezione di un figlio». La Bella Veneziana fu assolta
e Napoli impazzì di gioia. Centinaia di donne lo portarono in
trionfo cantando in coro: «tu hai difeso a causa, Alfredo Catapano,
e mò ‘a gente ‘e mane sbatteno pe’ttè».
Matilde Serao commentò la vicenda: «Se si uccidessero
tutti gli uomini che vedono una bella ragazza e se ne innamorano, non
crescerebbero più gli uomini». Animo tormentato e malinconico,
Catapano morì di morte volontaria il 28 febbraio 1927. Giovanni
Napolitano, anch’egli avvocato e poeta, nonché padre del
nostro Presidente della Repubblica, gli dedicò un libro e una
intensa poesia, Illusione di eterno, che si configura come
un potente inno alla vita.